Il confine è l'anima di Gorizia (4/8/2025 - l'Adige)
- Maurilio Barozzi

- 4 ago 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 6 ago 2025
Per la sua posizione, Gorizia è sempre stata una città crocevia tra i mondi romanico, germanico e slavo. Nel 2025, con la sua gemella Nova Gorica, è Capitale europea della cultura.

Maurilio Barozzi - Le Città nei libri/16
Due stati, oggi, condividono la stessa piazza di fronte alla stazione ferroviaria: uno è la Slovenia, che la chiama Trg Evrope, l’altro è l’Italia, che invece preferisce Piazza Transalpina. Attorno, adagiate come sorelle siamesi, le città di Nova Gorica e Gorizia. Ci sono volute le complesse chirurgie dell’Unione europea e dei trattati di Schengen - cui la Slovenia ha aderito nel 2004 e nel 2007 - perché le due città fossero rigirate e ricucite frontalmente, dopo che per anni si erano date la schiena, torturate da un filo spinato. A proposito, racconta Guido Piovene di un matrimonio tra un uomo italiano e una donna di origine slava che si festeggiava nell’osteria della stazione, sul confine. Per salutare gli sposi, due zie della ragazza si affacciarono vicino alla sbarra della frontiera, sul versante jugoslavo, dietro all’impassibile sentinella. Appena le scorse «lo sposo si portò la mano alla bocca e gridò: “Zie!”; si videro, dalla par te opposta, le due sventolare la mano. Un altro giovane lanciò un sacchetto di confetti, ma esso ricadde nel piazzale, ai piedi della sentinella. Poi le zie si voltarono e sparirono». Siamo nel 1953.
«Da ogni parte confini separano e uniscono tante cose diverse», riflette Claudio Magris nel suo intenso romanzo “Un altro mare” la cui storia è ispirata dalla soffitta Paternolli, a Gorizia, e dalla breve esistenza di Carlo Michelstaedter, illustre letterato cittadino morto suicida a 23 anni nel 1910.
Mario Soldati ricorda come nel 1970, al confine di Gorizia, il figlio avesse dovuto lasciare in Italia le macchine fotografiche per poter transitare in Jugoslavia. Scrisse anche: «Felici le persone che vivono presso i confini dello Stato, da una parte o dall’altra! (…) Felici e privilegiate: in tempo di pace, si capisce. (…) Perché, sebbene io mi sappia, dalla nascita, e per costituzione, contrario a tutte le frontiere e di qualsiasi specie, benedico le frontiere per la gioia che si prova a superarle e, se necessario, ad infrangerle: gioia che non si proverebbe se non esistessero».
La gioia del superamento, tuttavia, non sempre fu sentimento a portata di mano. La stessa stazione, oggi sul confine, fu costruita assieme alla linea ferroviaria nel 1906 sotto l’impero austroungarico per collegare Vienna al litorale senza passare da Udine che dal 1866 era nel Regno d’Italia. E, lì appresso, il ponte Salcano: il ponte con il più lungo arco in pietra al mondo. Un ponte maestoso per guadare l’Isonzo, fiume dal colore azzurro vivo in cui «si sono fusi lo struggimento dei nevai delle Giulie e la nostalgia dei pianori carsici», evoca il poeta Biagio Marin. Che poi continua, ricordando la guerra che in quei luoghi ha picchiato duro: «Per salvare all’Italia la chiostra delle Giulie e il nume che essa racchiude, milioni dei nostri si sono battuti e molti sono morti. E Gorizia era la perla della terra, ai piedi degli altipiani, la perla tra i fiumi». Una perla fin dai tempi del medioevo custodita dal castello, costruzione dell’«uomo, che nella polpa molle della marna e dell’argilla sprofondò strati di roccia, e le pietre innalzò nel cielo e nella pietra arcuò occhi neri che bevevano la luce dei colli a ridosso, dei monti nel cielo, della piana sfuggente, col fiume che luccicava», ancora Marin.
Pur non essendovi mai stato personalmente, Ernest Hemingway ambienta a Gorizia svariate scene di “Addio alle armi”. «La città era molto carina», scrive «ed ero molto contento che gli austriaci avessero l’aria di voler tornare nella città a guerra finita, perché così non la bombardarono per distruggerla, ma soltanto un poco, colpendo obiettivi militari». In effetti, passeggiando lungo Corso Italia, le intonse, ottocentesche ville in stile liberty, eclettico, gotico fanno respirare l’aria mitteleuropea del periodo teresiano. Anche se la via più pittoresca, capace di rappresentare l’anima mercantile della città, e dunque simbolo d’incontro, è via Rastello. Una strada lastricata di sanpietrini, illuminata da lucernarie in ferro battuto e dove, fino a qualche anno fa, pullulavano botteghe e negozietti, magneti ammalianti anche ai tempi della cortina di ferro per avventori e contrabbandieri provenienti dal mondo slavo. Lì potevano comperare scarpe, utensili, piccoli elettrodomestici e soprattutto jeans, da esibire o rivendere a Est.
Oggi, oltre venticinque anni dopo la caduta del Muro di Berlino, sebbene somigli al «filo di seta» vagheggiato da Silvius Magnago, quel confine non è stato cancellato. Permane anche nell’estetica: Gorizia mantiene il suo decadente fascino di «Nizza asburgica» ben distinto dai palazzoni in stile brutalista di Nova Gorica, che in compenso si giova dei silvestri dintorni, compresa la sorgente dell’Isonzo (che in Slovenia si chiama Soča). Pure nella piazza della stazione resiste il simbolo della divisione: oltre ai due nomi, una stele demarca il lato italiano e quello sloveno. Ma proprio questo è il senso di conferire il fregio di capitale culturale europea 2025 alle due città, siamesi seppur diverse: nessuna identità condivisa ma la riconosciuta capacità di collaborare in pace. Un passo della lode al vino del poeta sloveno France Preseren “Brindisi” recita: «Il vicino non dovrà essere un diavolo, ma un amico». Chissà se sarà mai davvero così, tuttavia l’auspicio è già un viatico importante. E quel brano, in Slovenia, è inno nazionale.
(Maurilio Barozzi, L’Adige 4/8/2025)

Galleria fotografica di Gorizia





























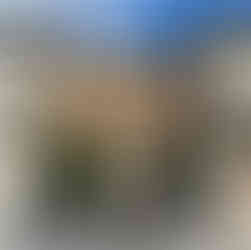





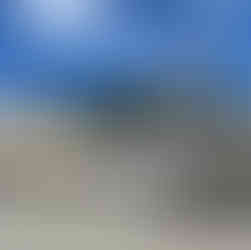
















































Commenti